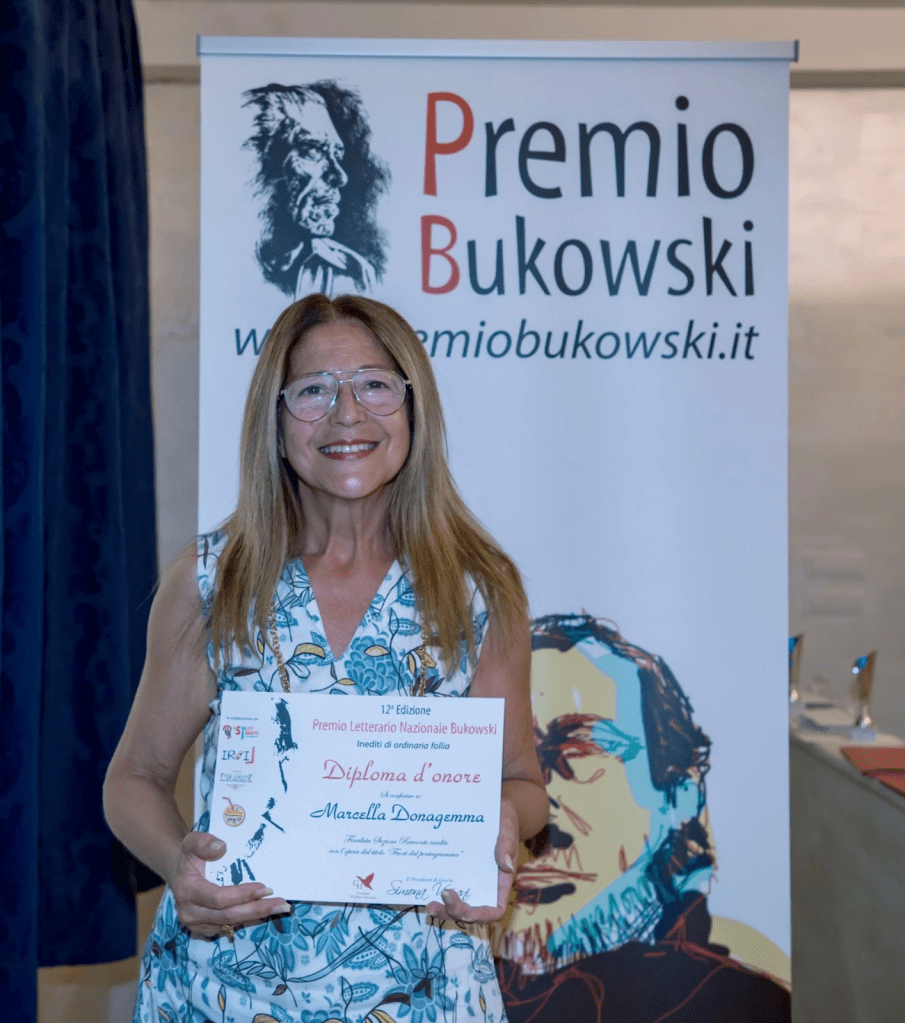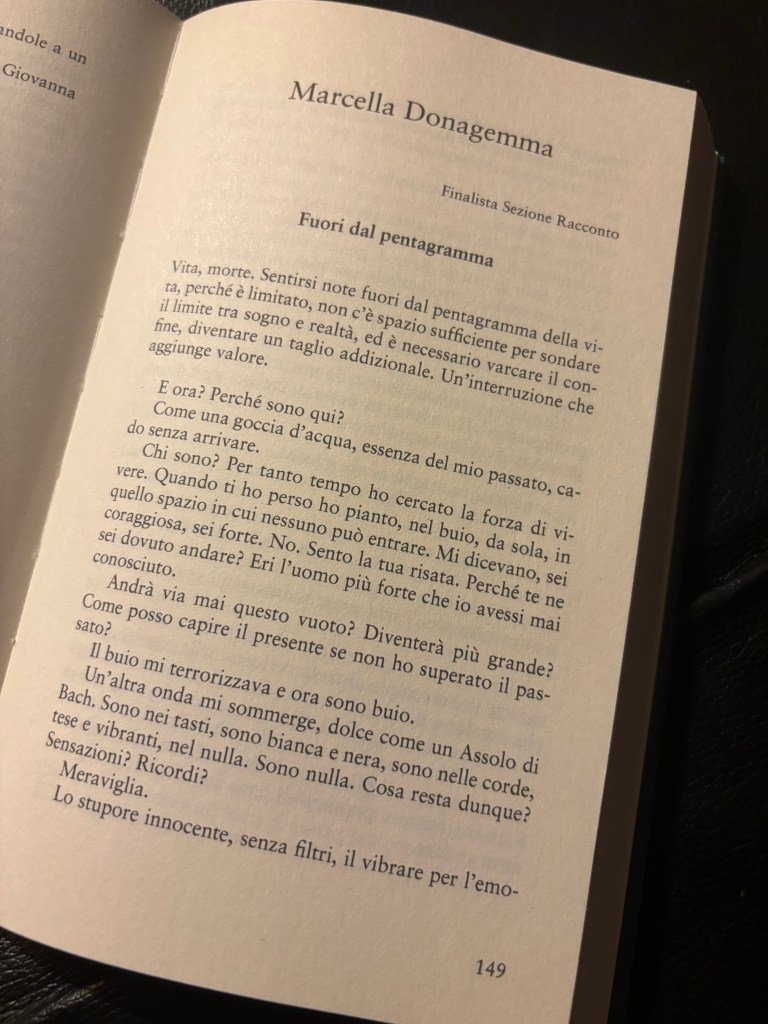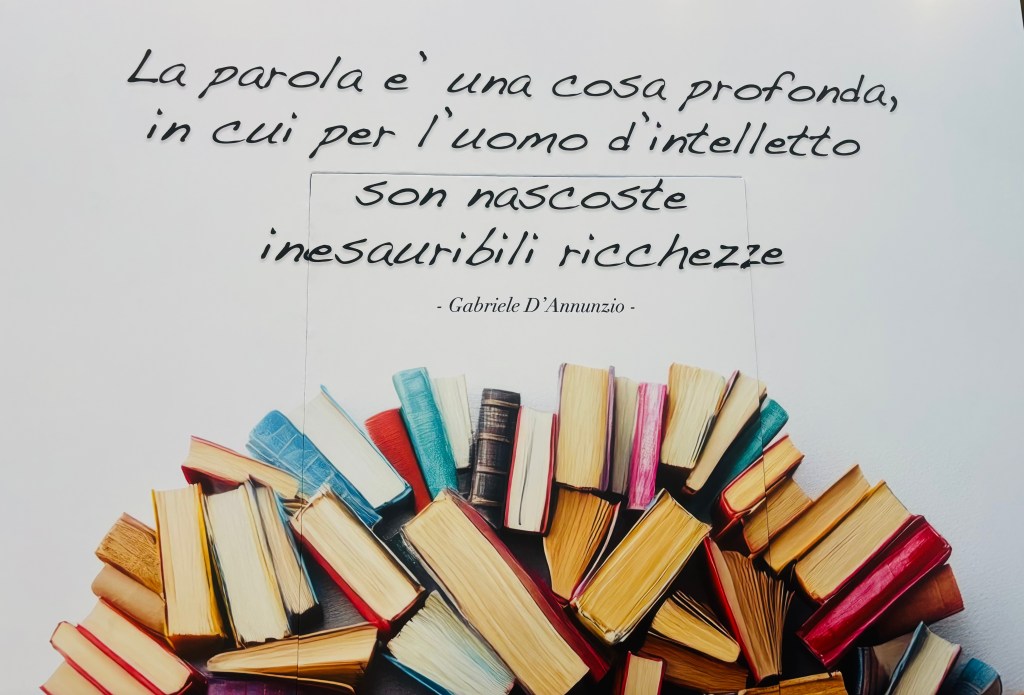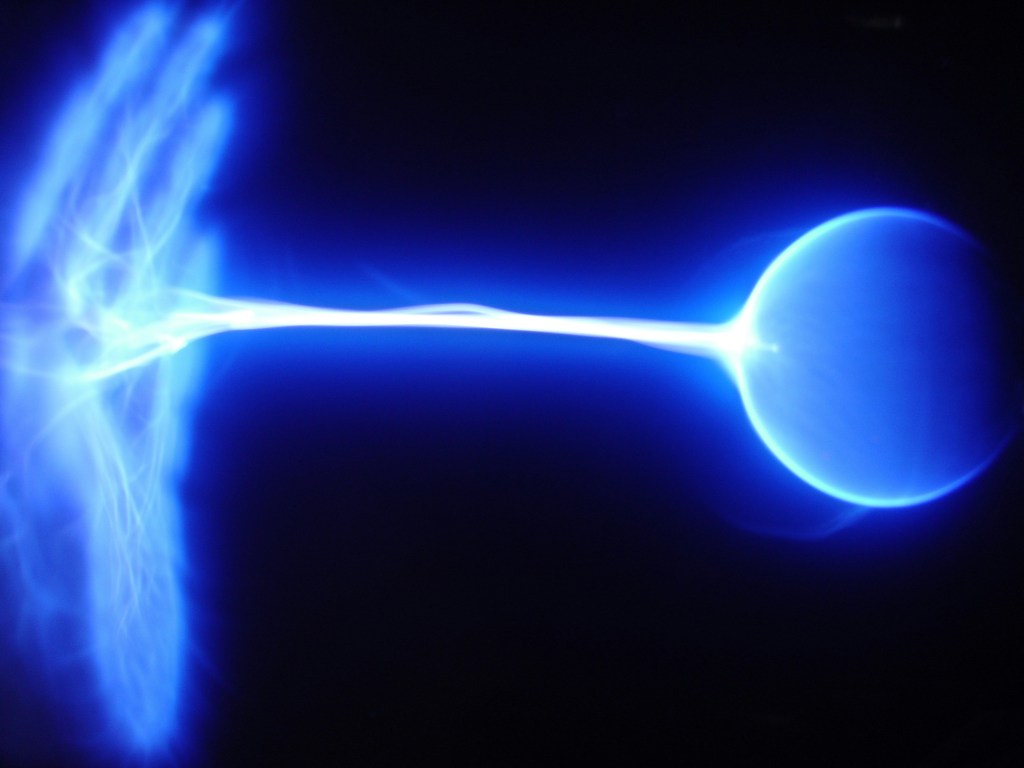Perché oggi si legge poco? Sapevate che, alla fine del Quattrocento, Venezia era il il centro culturale del mondo? Contava circa 150 tipografie, mentre Parigi appena 40. Un terzo dei libri che circolavano in Europa nasceva lì. Tantissimi libri.
È in questa Venezia che nel 1490 arriva Aldo Manuzio e non si limita a fare l’editore, di fatto inventa l’editoria moderna. Fonda le Edizioni Aldine. Ha quarant’anni, viene dal Lazio, conosce profondamente il greco e il latino e ha un’idea molto semplice e molto ambiziosa: stampare i classici, non per pochi eruditi, ma per chiunque avesse voglia di leggerli.
Ma la vera rivoluzione è nel modo in cui li pensa. Il libro come compagno quotidiano, non come oggetto sacro da consultare con timore. É così che inventa i LETTORI.
Fino a quel momento i libri erano oggetti grandi, pesanti, costosi, destinati a biblioteche, monasteri, studiosi. Manuzio li ribalta. Cambia il formato, cambia i caratteri, mette ordine nella punteggiatura.
Nel 1501 pubblica un Virgilio che passa alla storia non per il contenuto, ma per la forma. È il primo libro tascabile. Un volume che puoi tenere in mano, portare con te, leggere nel tempo libero, persino in guerra. Lo chiama Enchiridion, “ciò che sta nel palmo”. Lo ottiene piegando più volte lo stesso foglio fino a ricavarne otto pagine piccole: l’ottavino.
Per rendere quei libri ancora più accessibili, Manuzio inventa anche il Corsivo, ispirato alla scrittura a mano. Serve a rendere la lettura più fluida rispetto al carattere Gotico, e a risparmiare spazio: meno ingombro, più libertà. Ancora oggi quel carattere si chiama “italico”, in suo onore. A lui dobbiamo anche la punteggiatura moderna, quei segni minuscoli che organizzano il pensiero e rendono la lettura possibile.
Manuzio era convinto che i libri potessero cambiare il mondo. Scrisse che, “se si maneggiassero più libri che armi, ci sarebbero meno stragi e meno misfatti.” Non era un sognatore isolato: ebbe successo immediato. Nel 1502 una sua edizione di poeti latini vendette 3000 copie, un numero impressionante anche per l’editoria moderna.
Aldo Manuzio non ha solo stampato libri, ha creato le condizioni perché qualcuno li leggesse. Ha trasformato la lettura in un gesto quotidiano, personale, libero.
Non è vero che oggi si legge meno in assoluto: si leggono moltissimi testi, messaggi, post, titoli. Ma si legge diversamente.
La lettura lunga e immersiva, quella che costruisce pensiero critico e memoria, fatica a trovare spazio in un ambiente che premia l’urgenza e l’emozione immediata. In questo senso il problema non è la tecnologia in sé, ma il modello culturale che la governa.