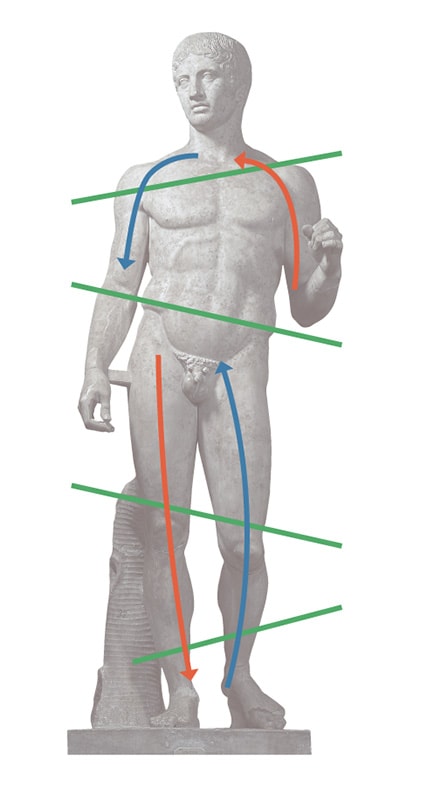Ho gli occhi chiusi per far agire meglio il collirio. Sono elettrica. Sigarette, vietate. Non per la salute ma per non rischiare di bruciare qualche abito. A tre a tre, sedute davanti agli specchi per il trucco e parrucco, circondate da hair stylist e make-up artist, spazzole, phon, pennelli che sbuffano polveri leggerissime come soffi di fumo.
Ho proprio voglia di una sigaretta.
La pelle del mio viso è tirata come un palloncino pronto ad esplodere. Mi hanno messo dei cerottini per allungare la forma degli occhi. Sembro una giapponese incazzata ma, loro, i giapponesi, non lo danno mai a vedere. Nella prova vestiti hanno fatto fatica a chiudermi la cerniera.
Mi sento gonfia.
Sono tre giorni che mangio solo un pezzetto di formaggio e bevo anche poco. Questa mattina ho pesato le mie feci, come sempre: 65 gr. È il diuretico di ieri sera che non ha fatto molto effetto.
Mi sento gonfia.
“Via, via! Sbrigati!”
E mi metto in fila, coperta da una vestaglietta col logo. Siamo tutte con un vestaglietta col logo. Tutte alte uguali, ma io, sono la più gonfia. Sento le sarte davanti alla fila, stanno urlando, chiedono delle spille da balia. Come in una catena di montaggio, chi è pronta, scivola di lato e passa il controllo finale.
Lu, è là. Lo stilista, posseduto da un’energia che opprime tutto il backstage.
Ogni volta è così.
Ogni volta prendo dei calmanti, ma non troppi, se no rischio di non reggermi in piedi. E ho i piedi gelati. Tocca già a me? Qualcuno mi toglie la vestaglia, due mani mi girano e sollevano le mie braccia.
“Trucco!”
Passano della cipria, forse del talco, sotto le mie ascelle.
Ogni volta è così.
Mi infilano un cappuccio macchiato che odora di creme, serve a proteggere la pettinatura e il trucco. L’abito mi cola addosso, si uniforma al mio corpo come una seconda pelle. E ancora mani. Che stringono il tessuto, che lo lisciano, e la cerniera sale. Per un attimo sento la pelle bruciare, come se fosse stata pizzicata o graffiata da un uncino. Via il cappuccio. Mi girano intorno come api impazzite, uno mi ha colpito il ginocchio destro. È arrabbiato, si vede. Il ginocchio mi fa male ma devono ritoccarmi il trucco.
Di colpo, le voci si abbassano, i visi si allargano in sorrisi.
Lei, sta passando.
Gli occhi anelano un suo sguardo, un saluto anche solo accennato. Lei è famosa, famosissima. Lei, non è più una ragazzina, ma è una dea. Ha il suo spazio, quasi un camerino, i suoi professionisti, la sua acqua e i suoi fiori. Li chiamano carisma, quella lunga falcata che non deve chiedere permesso e quel profilo in cui si stenta a riconoscere un naso, ritoccato così tante volte da sembrare trasparente. Non sarò mai come lei.
Tocca a noi. Come ballerine di fila, una vicina all’altra, perfette e anonime.
Un braccio che si alza, un “VAI”, e sono dentro alla luce, affogo nella musica, procedo con i miei piedi freddi, in scarpe troppo grandi, senza vedere veramente nessuno. Lo sguardo fisso davanti a me, sulla schiena di chi mi precede. Il sangue pulsa piano, la testa è leggera, tanti flash e tanti passi.
Ogni volta è così.