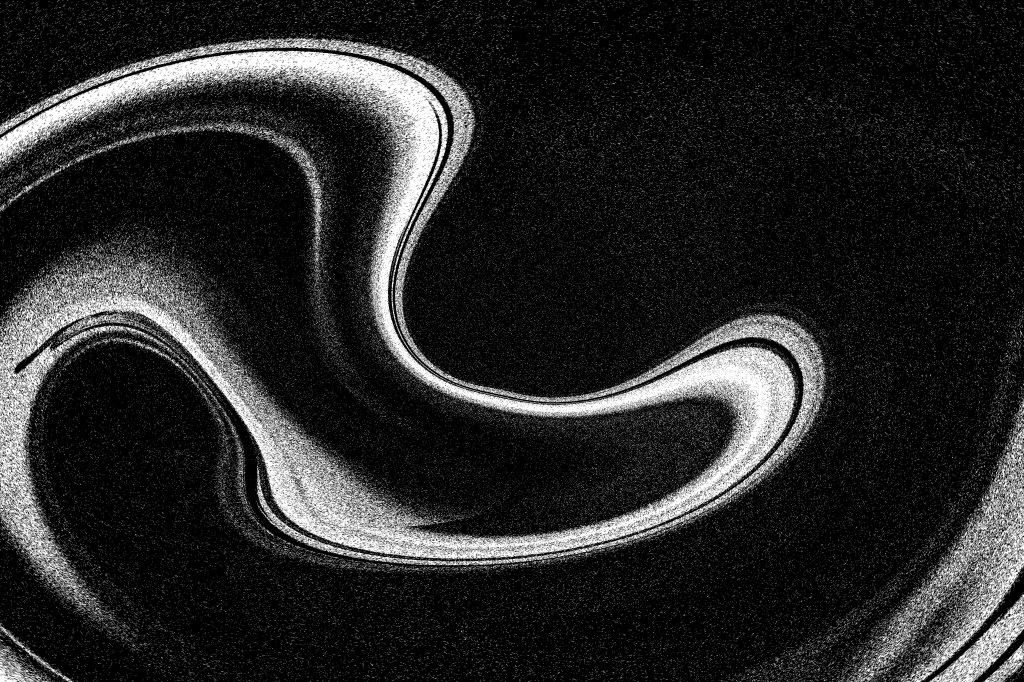Chiudi gli occhi. Ascolta. Cosa vedi? Lascia perdere che hai fame! Riesci?
Non importa, va bene lo stesso. Cosa vedi? Io ho chiuso gli occhi e ti ascolto.
Io vedo la stessa stanza in cui eravamo prima, piena di gente. Mi sembra di sentire anche caldo, mentre qualcosa di fresco e amaro mi si scioglie in bocca e scivola tra i denti, sotto la lingua. Forse sono state le sigarette, troppe. Sento un profumo di gelsomino arrivare da fuori, dal balcone.
Sì, lo percepisco anch’io quel panorama che si perde fino al tramonto. Come una distesa, un blocco di mattoncini lego che spariscono sotto il cielo pesante che si sta spegnendo. Presto sarà tutto nero. Quasi solido.
Chi è? Con chi stai parlando? É bionda? Ha una voce da bionda, le braccia lunghissime e tanti bracciali che tintinnano. Vanno al ritmo della musica che viene dal salone, dove sono tutti in silenzio e stanno ascoltando qualcuno che tocca il piano.
Mi sembra di vederle le note, come tanti uccellini che svolazzano sbattendo contro le pareti e il soffitto, ma non toccano le persone. Uno, colorato, si è fermato sul piano, è immobile. Lo vedi anche tu?
La senti la musica vibrare tra le vertebre, salire e scendere come se stesse cercando una direzione? Ora si è come incastrata, proprio tra le spalle. Solo una nota, di tanto in tanto, sale fino alla testa. Di tanto in tanto accarezza gli occhi per poi scivolare di nuovo lungo la colonna vertebrale, fino ai piedi. E sparisce. Quando arriva, sparisce.
No! Non applaudite. Sì, capisco che era un personaggio famoso ma avete rotto l’incanto.
É tornata la luce dei lampadari, il tintinnio dei bracciali e quelle braccia lunghissime che arrivano ovunque. Mi è rimasta una nota tra le scapole, se ne sta lì, ferma.
Lasciami così, per un po’, lasciami ferma a sentire questo buio. Sì, tra poco riapro gli occhi. Tra poco.