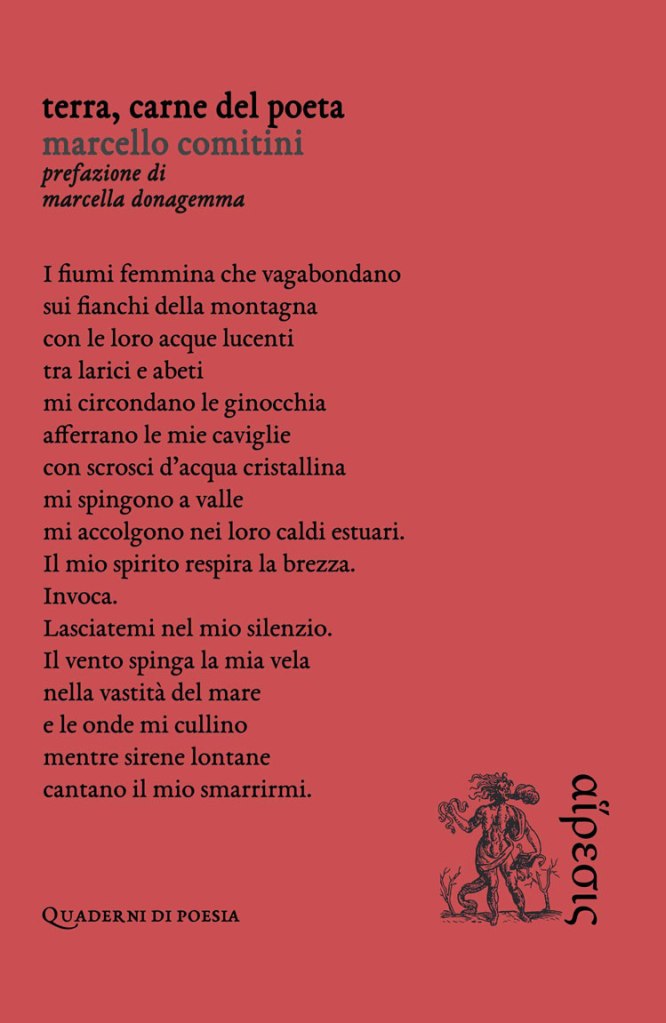Se ne stava seduta su una seggiolina, guardandosi intorno. Era arrivata da quasi dieci minuti, e la tensione stava salendo. C’era silenzio in quella parte del palazzo, una casa isolata, non antica ma vecchia, in mezzo ad un grande parco comune. L’inconfondibile odore di muffa e terra bagnata saliva dalla tromba delle scale fino al suo piano, l’ultimo. Sembrava che fosse l’unico appartamento abitato. D’altra parte, il “mestiere ” dell’inquilina, poteva mettere un pò a disagio. Si era fatta convincere da un’amica che la frequentava da tempo, ed era entusiasta delle potenzialità della signora.
Stava fissando una mattonella sul pavimento quando sentì aprirsi il chiavistello della porta. Voci, una signora elegante che ringrazia ed esce veloce, saluta appena e scende di corsa le scale. Dietro la porta, nella penombra, una figura scura la invita ad entrare, parlando veloce. Neanche il tempo di alzarsi ed entrare in un ingresso poco illuminato, che da una stanza poco più in là, qualcuno le chiede, o meglio, le dice, di chiudere la porta.
Pochi passi e si trova in una stanza piena di immagini sacre, profumata con, al centro, un tavolo e delle sedie. Una signora dai lunghi capelli neri raccolti in una lunga treccia, le chiede il nome, la invita ad accomodarsi.
“Stia tranquilla. Se non vogliono parlare con lei, non verrà nessuno.”
E l’ansia cresce.
Potrebbero non volermi parlare? Certo. In fondo forse li disturbo.
“Guardi che non li disturba.” La signora stava spargendo alcol nell’aria.
“Per gli spiritelli. Sono davvero snervanti.”
Meglio non chiedere. Da dove comincio?
“Allora, ce n’è uno di fianco a lei.” Intanto la signora stava scrivendo, assorta, e non si fermava.
“Comincia con la lettera F. Lo spirito è una donna, e le vuole bene. Perché le vuole parlare?”
Continuava a scrivere, sembrava una furia, riempiva pagine con una calligrafia che sembrava un disegno.
“Potrebbe essere mia mamma…”
“Non parli con me, parli con sua madre.”
Non ce la faccio, non ce la faccio. Ma che sto facendo? Mamma, se sei tu, voglio solo dirti che mi dispiace, mi dispiace.
La voce non le usciva. La medium si fermò, alzo lo sguardo, due occhi scuri e vuoti. Le prese le mani e le sembrò che le luci della sala brillassero, mentre avvertiva una sensazione di assoluta calma. La signora riprese a scrivere.
“Non so se sia sua madre, di certo le vuole bene e sta bene. Sta parlando di una scatola o un contenitore, qualcosa che sembra importante… Ora se ne è andata. Ci sono anche altri due, sono voluti venire, uno è davvero piccolo, è una bambina, molto intelligente, mi sembrava un adulto, l’altro invece sta parlando di una pipa.”
” Papà! Sei tu? E la bambina? Dice qualcosa?”
“La sta osservando, non la conosce molto, è curiosa… intelligente. G o C, no, G.”
La mente che sta impazzendo, G. Chi conosco che comincia con G? Anzi, chi conoscevo. Ma il mio papà? Non dice più niente?
“Mia cara, sono attimi. Perdono molta energia quando si manifestano. Solo nei film si fanno quattro chiacchiere… il fatto che siano venuti senza chiamarli è davvero un bel segno. La pensano quando lei li pensa, ma sono altrove, hanno altro da fare.”
La seduta si conclude e le sembra che sia durata pochissimo, invece è passata quasi un’ora. La signora è spossata, muove il collo e parla veloce.
Lei paga un’offerta, si alza seguendo la treccia nera che oscilla sulla schiena della signora, saluta nella penombra dell’ingresso ed è fuori.
Non sa se è delusa o sconvolta o dubbiosa. Certo, aveva azzeccato le iniziali di mamma, e la pipa la fumano in molti, ma la lettera G? Quella bambina.
GIADA! La prima figlia di mio zio! Saranno passati più di 40 anni…
Cosa le rimaneva di questa esperienza? Una sorta di tremore, le mani sudate, l’insicurezza e una voglia incredibile di piangere.
A casa, a casa cercherò la scatola dove mamma metteva tutte le foto e i suoi scritti. A casa.
E s’incamminò sul selciato tra gli alberi, respirando, guardando il cielo.
foto da unsplash